L’omologazione non l’ha inventata l’intelligenza artificiale
Superficialità, presenza e assuefazione nella comunicazione del presente
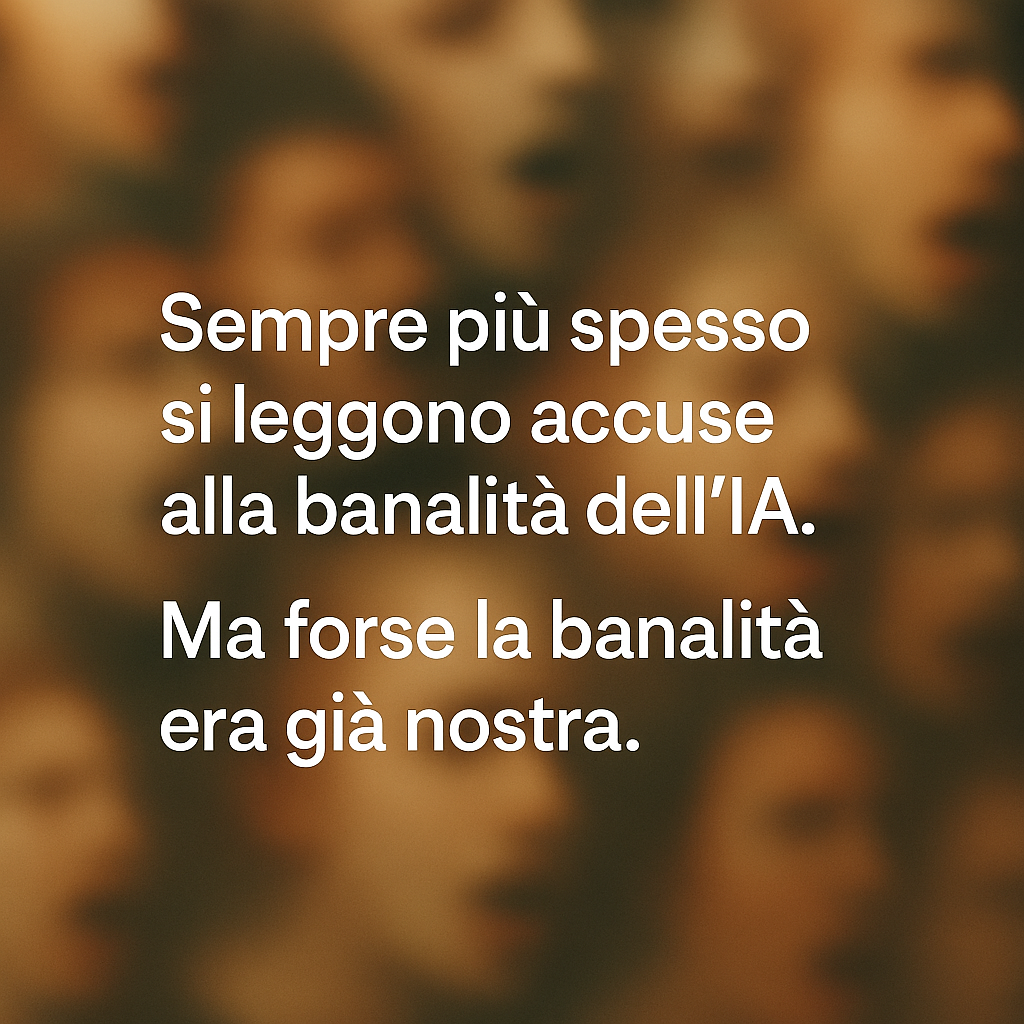
Si dice spesso che l’intelligenza artificiale stia rendendo tutto uguale, piatto, prevedibile.
Si teme che i testi prodotti da un algoritmo siano privi di voce, senza sfumature, incapaci di dire qualcosa di davvero umano.
È una critica che ha un fondo di verità, ma non nel punto in cui la si colloca.
L’IA non ha creato la banalità: l’ha solo ereditata.
È arrivata in un mondo in cui la comunicazione era già stanca, piena di formule che si ripetono e di frasi che si somigliano tutte.
Da anni viviamo dentro una comunicazione continua, che non ammette pause.
Nei social la regola è chiara: chi tace scompare.
Un profilo che non pubblica per qualche giorno smette di esistere.
Gli algoritmi premiano la frequenza, anche quando ciò che pubblichiamo ha poco da dire.
Anche contenuti di valore vengono penalizzati se non arrivano con costanza.
Conta più esserci che dire.
Posto, quindi esisto.
Questo ritmo ha cambiato il senso stesso del comunicare.
Le parole servono meno per esprimere un pensiero e più per restare visibili.
Il linguaggio si accorcia, diventa immediato, emotivo, replicabile.
Scriviamo come se avessimo sempre fretta, e forse ce l’abbiamo davvero.
L’originalità oggi rallenta, e chi si discosta dal tono medio rischia l’invisibilità.
L’uniformità è diventata la condizione per essere ascoltati.
Non è solo un fatto dei social.
Anche i giornali e i telegiornali vivono ormai dentro la stessa logica.
I titoli devono catturare in due secondi, gli articoli essere brevi e leggibili mentre scorri il telefono.
Le analisi e gli approfondimenti vengono compressi o spostati ai margini.
Le notizie non si raccontano più per capire, ma per restare nel flusso.
Tutto deve arrivare subito, e subito essere dimenticato.
Viviamo dentro una comunicazione aumentata.
Mai nella storia così tante persone hanno potuto parlare, scrivere, condividere.
Siamo davvero nell’era della comunicazione di massa, non più quella dei mass media, ma quella dei molti che parlano ai molti.
È un cambiamento enorme, e in gran parte positivo.
L’accesso diffuso alla parola è un fatto democratico e liberante.
Il punto è che a questa apertura non è corrisposto un salto di qualità.
Non possiamo accontentarci di una comunicazione che parla solo alla pancia, che cerca consenso immediato, che riduce la complessità a emozione.
Una comunicazione che muove ma non spiega, che tocca ma non approfondisce.
Scorriamo, leggiamo, reagiamo, ma sempre in superficie.
La superficialità non è più un’eccezione: è diventata il modo normale di stare nello spazio pubblico.
Il rischio è che ci basti la reazione, senza il pensiero che dovrebbe seguirla.
La frequenza ha preso il posto della profondità, la quantità ha sostituito il valore.
Essere presenti è diventato più importante che dire qualcosa che resti.
Oggi comunichiamo per non sparire, più che per condividere un senso.
Dentro questo scenario, l’intelligenza artificiale non fa che riflettere ciò che trova.
I modelli linguistici imparano da noi: se parliamo in modo uniforme, produrranno uniformità.
Quando li accusiamo di scrivere testi tutti uguali, in fondo stiamo criticando noi stessi.
La tecnologia non ha fatto che rendere visibile la forma del nostro linguaggio collettivo.
Il problema non è la macchina.
È l’assuefazione: l’abitudine alla superficie, che confonde l’emozione con il pensiero e la visibilità con il contenuto.
Forse la semplicità consola, ci fa risparmiare fatica e tempo, ci fa credere di capire tutto senza pensarci troppo.
Ma questo sollievo ha un costo: ci toglie profondità, e con essa la capacità di distinguere.
L’omologazione della comunicazione non è colpa dell’IA.
È un’abitudine che abbiamo costruito noi, giorno dopo giorno.
Questo articolo vuole andare in questa direzione: interrogare il linguaggio del presente, la sua velocità, la sua stanchezza, e la nostra crescente tolleranza verso la superficialità.
Ne verrà pubblicata anche una versione sintetica per i social, che rimanderà a questo testo completo.
È stato co-scritto con strumenti di intelligenza artificiale, proprio per riflettere — anche nella forma — il tema di cui parla.
Pier Luigi Lai
***
Riferimenti
Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare (1964):
“Il medium è il messaggio.”
“Ogni tecnologia è un’estensione di noi stessi.”
Neil Postman, Divertirsi da morire (1985):
“Gli americani non si parlano più: si intrattengono. Non scambiano idee, ma immagini. Non discutono con argomenti, ma con l’aspetto, la celebrità e la pubblicità.”
Byung-Chul Han, La società della trasparenza (2012):
“La società della trasparenza non solo manca di verità, ma anche di apparenza simbolica.”
“La società diventa oscena quando non c’è più una scena, quando tutto diventa inesorabilmente trasparente.”


